“Scrolling infinito è un lungo lavoro di induzione con lo scopo di costruire un sistema teorico che tenga assieme le buone …

La piazza di discussione del Filo di Arianna


“Scrolling infinito è un lungo lavoro di induzione con lo scopo di costruire un sistema teorico che tenga assieme le buone …
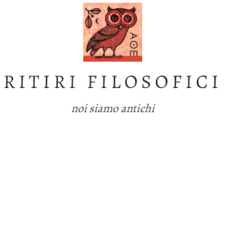
Molto interessante questo sito di filosofia https://ritirifilosofici.it/ Dalla presentazione: Noi non siamo un gruppo di consulenza filosofica, né abbiamo inteso …

Uno dei temi più caldi di questi mesi è vedere se e come i nuovi software LLM possono essere utilizzati …

Ecco 50 domande nozionistiche su Socrate.
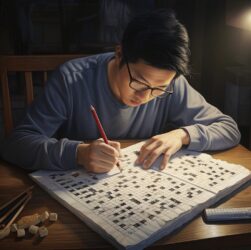
Gli studenti non conoscono più nemmeno le parole più facili

Una delle città invisibili di Calvino, rilette da Midjourney

In quinta liceo un argomento centrale per storia è la Prima guerra mondiale, argomento sul quale più volte ho somministrato …

Una classe davvero in gamba!

La materia di storia viene erroneamente considerata facile ma in realtà è la più difficile di tutte.

Ci sono due principi che potrebbero essere un solido punto di partenza per fornire linee guida sul comportamento da tenere …